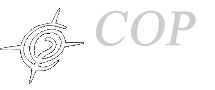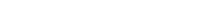Bonicelli: i laici nell'ottica paolina.
Gaetano Bonicelli, Presidente emerito del COP ed Arcivescovo emerito di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino, sottolinea l'impegno del COP per la riflessione sui laici, dalla collaborazione alla corresponsabilità: ben 10 settimane nell'arco di 61.
Fonda il suo intervento biblicamente.
Non era un problema, quello dei laici, nelle prime comunità cristiane che facevano capo a San Paolo. In un recente studio di Romano Penna, il biblista sostiene che la Chiesa attuale, soprattutto se basata sull’ottica paolina, dovrebbe imparare a darsi una struttura ministeriale più snella, che non rimarchi troppo la distinzione (che è storicamente secondaria!) tra preti e laici. A leggere i moltissimi nomi di collaboratori di San Paolo c’è da meravigliarsi che in larghissima parte siano semplicemente laici, uomini e donne, a cui l’Apostolo si rifà per servire e sostenere le sue comunità. In un secondo momento però, anche in San Paolo, alcuni sono considerati responsabili che garantiscono la continuità dell’evangelizzazione e il ministero della grazia.
Il vescovo richiama poi il magistero del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Nel nr. 33 di Lumen Gentium, seguono alcune precisazioni. «I laici, radunati nel Popolo di Dio e costituiti nell’unico Corpo di Cristo sotto un solo capo, chiunque essi siano, sono chiamati come membri vivi a contribuire con tutte le loro forze, ricevute dalla bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore, all’incremento della Chiesa e alla sua continua ascesa nella santità. L’apostolato dei laici è quindi partecipazione alla stessa salvifica missione della Chiesa, e a questo apostolato sono tutti destinati dal Signore stesso per mezzo del battesimo e della confermazione. Dai Sacramenti, poi, e specialmente dalla sacra Eucaristia, viene comunicata e alimentata quella carità verso Dio e gli uomini, che è l’anima di tutto l’apostolato».
Due sono di conseguenza i settori dove i laici possono e debbono operare: quello interno alla struttura ecclesiale e quello esterno non al fine ma all’organizzazione ecclesiale. Papa Ratzinger, nel suo discorso del 2010 ai romani, ritiene necessario migliorare al tempo stesso l’impostazione pastorale, così che, nel rispetto delle vocazioni e dei ruoli dei consacrati e dei laici, si promuova gradualmente la corresponsabilità dell’insieme di tutti i membri del popolo di Dio. Ciò esige un cambiamento di mentalità riguardante particolarmente i laici. Passando dal considerarli «collaboratori» del clero a riconoscerli realmente «corresponsabili» dell’essere e dell’agire della Chiesa, favorendo il consolidarsi di un laicato maturo e impegnato.
Superando la dicotomia chierici e laici, Bonicelli ricorda che l’identità dignitosa battesimale ci colloca alla pari nel popolo di Dio, che si specifica anche nelle differenti mansioni. Parlare dei laici e della loro prevalente responsabilità secolare, coinvolge naturalmente i pastori: non solo per la garanzia dei Sacramenti attraverso il loro carisma, ma anche per la loro opera di guide spirituali e di educatori al discernimento.
Congar, anche per i laici, parla del loro radicamento, sulla base del battesimo e della cresima, nel “sacerdozio regale” comune a tutti i fedeli. Tutto ciò evoca la chiamata alla santità. San Paolo non fa questione di chierici o di laici quando parla del culto spirituale che offre il nostro corpo come ostia vivente, santa, gradita e dovuta a Dio (cf. Rm 12, 1). Ma questo impianto spirituale, garantito dalla fede, non comporta per la Chiesa alcuna responsabilità diretta, salvo quella della preghiera e dello stimolo morale che tende a costruire il regno di Dio. Di conseguenza «per compiere la loro missione apostolica a titolo individuale, i laici non devono attendere una delega di poteri: basta loro di essere fedeli alle esigenze del loro titolo di battezzati e cresimati» (Nota Assemblea Cardinali e Arcivescovi francesi, marzo1946). Ma per far vivere lo spirito e la grazia della Chiesa “ad extra”, bisogna essere consapevoli di un autentico ruolo missionario.
Dopo aver richiamato l'opportunità di muoversi in gruppo, richiamando movimenti ed associazioni, interroga: "che genere di Teologia del laicato ispira la nostra comunità?".
Il sondaggio di Villata sul laicato in parrocchia: quali tendenze verso quella sinfonia delle vocazioni che permette una realizzazione di tutte?
Il laicato “nella Chiesa italiana c’è ed è vitale, anche se, in alcune diocesi, viene lamentata una diminuzione numerica e un’inadeguatezza ad esprimere al meglio la propria identità”, ha affermato don Giovanni Villata presentando i risultati di una ricerca condotta tra laici, sacerdoti e religiosi sul "laicato in parrocchia". Piuttosto “ciò che preoccupa, e non poco, è la situazione di afasia, o di mancanza di crescita oppure insoddisfazione di chi pur s’impegna, anche generosamente. Se questa situazione non evolve verso un recupero pieno, di fatto, dell’identità laicale nel contesto socio-culturale ed ecclesiale di oggi è possibile pensare che, da sola, la generosità del laicato stesso non sia sufficiente ad escluderne la deriva”.
“I dati che abbiamo raccolto – ha spiegato Villata – indicano chiaramente la presenza contemporanea, in parrocchia, di figure di laici (ma anche di ministri ordinati) tuttora ancorate al passato, accanto ad altre (laici singoli e aggregati nonché ministri ordinati) più proiettate verso la maturazione dell’identità conciliare. Tutte queste figure, attive nella vita della parrocchia, non sempre sono valutate come meriterebbero: quali cooperatori e quindi partner a tutti gli effetti, non solo come esecutori o collaboratori occasionali. Sovente esse, a causa dell’eccessiva esposizione mediatica della gerarchia, non hanno la possibilità di esprimere in pubblico le posizioni della Chiesa, pur in ambiti che sarebbero di stretta loro competenza. Tutti comportamenti che non sono più accettabili, vanno cambiati”.
In Italia, ricorda l’indagine, ci sono 23.000 parrocchie; 200.000 i laici che vi operano, tra catechisti e operatori pastorali: l’80% sono donne e, tra queste, il 70% ha meno di 50 anni. Al sondaggio del Cop hanno risposto 389 laici con un’età media di 46 anni, oltre a 89 sacerdoti e 38 consacrati (religiosi).
“Nella pastorale della Chiesa italiana – ha osservato Villata – da un lato si stanno cercando vie nuove per l’evangelizzazione e, dall’altro, si registra il ritorno di modelli tradizionali segnati da autoreferenzialità e clericalismo”, tendenze che emergono anche dal sondaggio. “L’identità secolare del laico è riconosciuta più in teoria che nella prassi”. Si constata poi “la crisi, in genere, degli organismi di partecipazione: nel campione – ha riferito il sacerdote – pochi riconoscono la validità e la funzionalità del Consiglio pastorale parrocchiale; i più ne denunciano il limitato o mancato controllo”. “In genere – ha aggiunto – si riscontra un buon clima relazionale tra aggregati, singoli e altre risorse pastorali” e un ruolo di primo piano, in parrocchia, lo riveste l’Azione cattolica, alla quale si riconosce una “peculiare funzione formativa”. Infine “il laicato è la spina dorsale della pastorale parrocchiale: la donna è apprezzata come la sua linfa vitale dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo. Non è più valorizzata solo per pulire, ma le si attribuiscono compiti di coordinamento e responsabilità dirette”.
Ammanati: è necessaria una formazione a tutto tondo.
Mi domando: a che punto siamo rispetto a questa visione? Senz’altro è necessario superare la tentazione di non accorgersi del cammino positivo percorso riguardo alla figura e alla identità del laico… dal Concilio in poi. Di certo i dettami di questo evento di Grazia sono tuttora da realizzare pienamente ma dobbiamo riconoscere che nella nostra chiesa italiana si è percorso un cammino. Talvolta è vero che nelle nostre parrocchie il laico è considerato più il “manovale” o il “tuttofare” ma è oltremodo evidente che ci sono realtà in cui si registra una bella e vitale comunione che porta a collaborazioni fattive e feconde, che generano corresponsabilità in termini di annuncio del Vangelo! E’ in questa prospettiva che dobbiamo intraprendere un cammino e domandarsi: Quanti sono i laici che nella nostra chiesa sono consapevoli della responsabilità che scaturisce loro dal Battesimo in termini di annuncio e di testimonianza? Quanti ministri ordinati hanno a cuore la loro formazione? Come Chiesa tutta, quanto abbiamo a cuore la loro formazione? Quali cammini formativi si attuano?
Una specificazione importante su ciò che intendo per “formazione”: si tratta di “prendere forma”. Per un laico cattolico questa forma non può essere che quella di Cristo. Dal Battesimo che ne segna l’appartenenza al popolo di Dio come sacerdote, re e profeta vi è da percorrere un cammino formativo che consenta a ciascuno di divenire ciò che già è nella realtà sacramentale della sua origine. Cosa occorre per prendere questa forma? Dobbiamo riconoscere che talvolta quel che attualmente si offre si risolve più in una formazione specifica che ha per obiettivo l’“abilitare” ad un servizio piuttosto che in una FORMAZIONE “A TUTTO TONDO” del laico perché sia autenticamente un laico cristiano che viva in una dimensione unitaria la fede con la vita. Occorre essere consapevoli che una formazione direttamente funzionale ai servizi che anche al laico sono richiesti (animazione liturgica, catechesi, educazione, etc…) non lo abilita completamente a vivere la pienezza della sua vocazione “nell’ordinare le cose temporali”. Quindi, accanto ad una dimensione contenutistica/catechetica di base certo necessaria per svolgere più propriamente i servizi di natura ecclesiale, è necessario recuperare la preziosità “fontale” della dimensione interiore, consentendo al laico di costruire, nei modi suoi propri, una spiritualità solida, robusta che sempre lo ri-orienti al modo di Cristo di giudicare le cose ed il mondo. Non si tratta quindi di imprimere nel laico i lineamenti spirituali tipici dei ministri ordinati o dei consacrati, ma, piuttosto, di suscitare il desiderio di appartenenza a Cristo ed alla Chiesa, come realtà che visibilizza il Cristo storico.
Vi è poi il delicato COMPITO DELLA PROSSIMITA’ che si fa CURA DELLE RELAZIONI: intra ed extra ecclesiali.