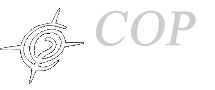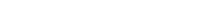Sigalini: prospettive pastorali
Il presidente del COP, S.E. Mons. Domenico Sigalini, come di consueto ha tracciato una sintesi di quanto emerso nelle relazioni ed interventi di questa LXI Settimana Nazionale di Aggiornamento Pastorale svoltasi a Firenze, città che con le sue "opere d'arte cristiana" ha ridestato il senso di come "l'umana professione possa parlare del Divino".
Il severo tirocinio della corresponsabilità.
Abbiamo iniziato con una successione di parole che scandivano la collocazione dei laici nella vita della chiesa, di una chiesa che nel tempo passava dal ritenersi come la società perfetta dei cristiani ad essere definita popolo di Dio, segno e strumento della comunione con Dio e degli uomini tra di loro. Le parole erano appartenenza, partecipazione, partecipazione attiva, collaborazione, e alla fine emergeva come la migliore che potevano dire la parola corresponsabilità. Pensavamo forse che il quadro fosse già ben definito, che si trattasse finalmente di chiarire solo come dover esercitare questo diritto dovere, ma la ricerca fatta in questi gironi con i vari apporti dei relatori e dei dibattiti a mano a mano ne hanno sviscerato i molteplici significati. Abbiamo capito che prima che un diritto da far valere, è un grande dovere da assolvere, che è dono di Dio, frutto di un percorso e di un tirocinio di crescita personale e comunitaria, che è un servizio evangelico che il cristiano è obbligato a rendere alla vita quotidiana dell’uomo, che è lo stile unico di una vera evangelizzazione, un modo obbligato di vivere ogni dimensione della vita cristiana, un servizio alla comunione dei cristiani nel mondo. Ma procediamo per gradi.
La mentalità comune.
Il primo punto di approdo è la consapevolezza di quale mentalità si è sedimentata nei nostri ambienti rispetto alla collocazione dei laici cristiani battezzati nella chiesa e nel mondo. Non siamo in presenza di rivendicazioni di ruoli, di frustrazioni di vocazioni o di contrapposizioni intolleranti, quasi che in Italia si debba temere una sorta di “indignazione” collettiva dei fedeli laici verso una chiesa arroccata nella sua gerarchia, ma di una consapevolezza di una chiamata di Dio e di un ideale che sta davanti a tutti e la constatazione che le prassi ecclesiali, le strutture di corresponsabilità, non sono ancora all’altezza della posta in gioco. Da una parte emerge una dedizione generosa al vangelo, un desiderio di comunione e di lavorare assieme, una tensione evangelizzatrice anche creativa e dall’altra la persistente consapevolezza che si può fare molto di più e meglio, essere molto più fedeli al vangelo e al Concilio Ecumenico Vaticano II e al suo difficile impiantarsi nella mentalità generale ormai a 50 anni dal suo inizio. E’ come se avessimo in mano una pietra preziosa, di cui sappiamo il grande valore e non sapessimo come valorizzarla, come incastonarla nella architettura della missione e della evangelizzazione della Chiesa. Addentrandoci di più nella analisi della vita dei laici cristiani in Italia si possono mettere in evidenza alcune ragioni storiche e teologiche che ne determinano una sorta di afasia o adattamento al ribasso: la tendenza alla autoreferenzialità sia laicale che di alcune componenti non marginali della istituzione ecclesiastica, ci si sbilancia più sul versante laico-chiesa che sul versante laico-mondo; infatti ci si rifugia spesso nel garantire servizi ecclesiali anziché lanciarsi nella trasformazione delle strutture della società, nell’umanizzazione del lavoro, nel rendere più abitabile la terra. Si stigmatizza, anche giustamente una serie di derive presenti in delicati ambiti della vita, della famiglia, di tanti temi sensibili e non si valorizza l’impegno dei laici nella storia. Insomma la composizione tra consapevolezza dei laici e fiducia delle gerarchie è un equilibrio da far continuamente crescere. Non aiuta molto la riflessione teologica che per affermare la laicità di tutta la chiesa, tende a destituire ogni specificità del laico. Il laicato è apprezzato e talora rassegnato, è carico di aspettative e nello stesso tempo lasciato a se stesso, senza stabili cammini formativi che lo aiutano a crescere. Si sa bene che le relazioni sono il perno della vita di una comunità cristiana, ma non vengono sviluppate nella direzione di una matura corresponsabilità; c’è consapevolezza che il laicato è la spina dorsale della vita di una chiesa locale, ma forse è ancora ai livelli di una splendida teoria. La nota più negativa è quella che fotografa il laicato in una sorta di apatia, favorita da un eccesso di esposizione della gerarchia in questioni più attinenti alla identità secolare. Qualcuno ha scritto che manca il respiro, ma non siamo in cerca di bombole di ossigeno da applicare o respirazioni bocca a bocca, ma di un cuore che batta all’unisono, perché l’aria c’è: lo Spirito Santo soffia e gonfia le vele della chiesa sempre.
La corresponsabilità laicale.
Dovendo continuamente parlare di corresponsabilità è giusto attestarsi su un significato condiviso. Lo prendiamo da una magisteriale relazione del Card. Tettamanzi al convegno di Verona del 2006: corresponsabilità è parte di una triade con altre due parole: comunione e collaborazione e ne sta al vertice, ne è la naturale completezza. Così è il pensiero di papa Benedetto, così è il punto di partenza del nostro convenire. E l’indicazione fondamentale che vogliamo assumere come COP e che sta alla base della settimana di aggiornamento è che essere corresponsabili della missione della chiesa significa innanzitutto evangelizzare nel mondo (Campanini). Mondo significa immediatamente territorio, significa farsi carico di una terra sempre più violentata e abitata da “turisti e vagabondi”, da gente sempre più sradicata per una mobilità lavorativa e da una fuga dagli orrori della fame, delle dittature, delle guerre. Significa farsi carico di un difficile equilibrio tra la prossimità di relazioni quotidiane, amicali e di collaborazione territoriale con le molteplici alterità che esigono riconoscimento. La religione cristiana non ha mai dato enfasi a contrapposizioni, ma ha sempre cercato comunione. Evangelizzare per i laici che si appassionano alla vita del mondo significa sposare i propri ambienti di vita, superare la tentazione della estraneità e abbandonare il recinto di una comunità autoreferenziale. L’attitudine dello stare ad aspettare, va cambiato con la decisione del mettersi in ricerca e del condividere mobilità; passare da una evangelizzazione statica a una evangelizzazione dinamica implica inevitabilmente la corresponsabilità dei comuni cristiani, di tutto un popolo di Dio. In questo contesto la figura del presbitero può essere ridimensionata non nella sua valenza teologica, ma nella impostazione della sua centralità nella organizzazione ecclesiastica. Ne consegue anche una ridefinizione della ministerialità che finora si è attestata solo su lettorato e accolitato e sui ministri straordinari della eucaristia verso una ministerialità diffusa, specificamente laicale, non legata a nessun specifico mandato, né esercitata in forma permanente. Una chiesa tutta ministeriale non è una chiesa clericalizzata, ma popolata di laici chiamati ad essere autentici evangelizzatori. A questo corresponsabilità laicale devono corrispondere anche alcuni luoghi in cui concretamente si esercita il discernimento e la stessa presa in carico di progetti e piani pastorali. C’è un opinione pubblica nella chiesa che deve trovare spazi per dirsi e per corresponsabilizzarsi. Non si tratta di mettere in dubbio la responsabilità di governo dei pastori e tanto meno di non riconoscerla, ma di favorire il lavoro comune ciascuno con il suo livello di responsabilità.
L’esercizio della corresponsabilità.
Affermato come punto di non ritorno che la corresponsabilità del laico è più estroversa, per intenderci, che legata alla staticità di una comunità, è uscire dalla logica della delega e obbedire alla propria vocazione di battezzato, prendersi le responsabilità nel territorio e vivere da adulto nella fede, evangelizzare nelle strutture sociali, politiche e amministrative, il prossimo passo importante da fare è delineare lo stile della corresponsabilità e la prassi conseguente. Per cristiani impegnati nelle istituzioni corresponsabilità non significa distribuzione di compiti, ma confronto e convergenza tra cristiani che operano nel territorio. Non esiste oggi responsabilità senza corresponsabilità, impegno nel mondo senza comunione. I laici cristiani purtroppo sono troppo divisi e la divisione non avviene per motivi di fedeltà al vangelo, ma si insinua molto prima, per interessi banali di bottega, per assolutizzazione di visioni palingenetiche, per rivalità di parte politica cui si è più legati che al vangelo. Non diamo al mondo una bella immagine se all’interno delle nostre chiese siamo divisi per gli interessi personali e per le appartenenze a una parte politica prima che alla dottrina sociale della chiesa e al vangelo. Non si sperimenta né responsabilità, né corresponsabilità, ma irresponsabilità. Si impone il superamento di particolarismi, chiusure, piccoli recinti, per costruire nel territorio percorsi di vera fraternità e comunione. C’è un forte spirito ecclesiale e una capacità di agire insieme per il bene comune da ricuperare .E questo è un martirio silenzioso da affrontare. Dice papa Benedetto che “la chiesa non è il risultato di una somma di individui, ma una unità di coloro che sono nutriti dall’unica parola di Dio e dall’unico Pane di vita. Dobbiamo sempre nuovamente imparare a custodire e difendere questa unità da rivalità, da contese e gelosie che possono nascere nelle e tra le comunità ecclesiali”
Ancora di più: chi si impegna politicamente, non deve sentirsi un appestato, deve sapere sperimentare sempre che la sua casa è la chiesa, che come compito primario per costruire percorsi di corresponsabilità offre al cristiano ascolto della parola e esperienza di fede, lì riceve forza per la testimonianza, anche rimprovero per l’infedeltà, perdono per gli errori. Nella vita quotidiana non siamo esenti dal pericolo di falsi profeti, di miraggi magari di efficace impatto sociale ma che potrebbero falsificare il vangelo. Il segno dei frutti e la loro corrispondenza allo spirito delle beatitudini diventa il luogo della verifica della coerenza che ogni corresponsabilità presuppone, se vuole davvero contribuire alla manifestazione del regno di Dio. Ricordiamo gli altri due termini della terna cui ci siamo affidati nel definire la corresponsabilità: comunione e collaborazione. “Non può esserci vero servizio se non nel contesto di un legame di comunione. In questa prospettiva appare evidente come la dimensione ecclesiale, intesa come luogo di esercizio della comunione, e la dimensione storica della vita credente, lungi dal contrapporsi, si implichino vicendevolmente. Solo un cuore aperto all’incontro e alla comunione può diventare sorgente di testimonianza e di servizio verso il mondo. L’esperienza del credente nella Chiesa costituisce la radice e l’apprendistato di una comunione che è il dono più proprio che egli può fare a tutti nell’impegno storico. In questo senso la Chiesa è lo spazio educativo della responsabilità storica” (Betori). Alla fine poi chi si impegna nelle istituzioni è consapevole che corresponsabilità richiede anche una autonomia decisionale che non risponde a nessuna delega del parroco o del vescovo (De Palo).
La corresponsabilità nella vita quotidiana.
Data l’impostazione generale e l’aver collocato la corresponsabilità più sbilanciata nella missione del cristiano nel mondo, abbiamo scelto di declinare la corresponsabilità non riferendoci a eventuali uffici ecclesiastici, che hanno il compito prezioso di curare le dimensioni vere della vita di un cristiano, ma di vivere tali dimensioni nelle pieghe della vita, della educazione della affettività, nel soccorso alle fragilità, nella inclusione di ogni uomo e donna, soprattutto del mondo giovanile, nella realtà del lavoro. Corresponsabilità in questi campi significa anche che non siamo per la fortissima specializzazione che caratterizza il tempo presente se spinge alla perdita di visione dell’insieme e si blocca sul particolare. Vuol dire che il cristiano con lo stile della sua corresponsabilità rimette ogni parte all’interno di un percorso che permette sempre di riscoprire il senso del tutto, ha un modo di affrontare le fragilità che è di offrire sempre un cuore, di mettere al centro la vita intera e non solo schegge di essa, di sperimentare il limite e per questo la necessità di un lavoro in massima collaborazione con tutti. Si apre a una accoglienza infinita, a una pazienza che non ha niente a che vedere con la cortesia degli sportelli che rispondono ai bisogni e alle fragilità ad orari e non nei giorni festivi. E’ capace di andare controcorrente nella cultura di una affettività incagliata in emozioni da vendere e comperare (Blasetti).
Corresponsabilità nella cultura e nell’educazione
La sfida della corresponsabilità in questo campo è di dar vita a progetti, esperienze, iniziative in grado di raccogliere le sfide del tempo, con esperienze popolari disseminate sul territorio, capaci di fare opinione e di generare un tessuto ecclesiale e culturale vivo. Si tratta di superare l’inerzia del cristiano medio, di assumersi il rischio di operare scelte spesso impopolari anche nei nostri ambienti, imitando l’intraprendenza del laicato del primo novecento, che ha aperto pure la strada a tante decisioni del Concilio ecumenico Vaticano II. La scelta urgente da fare è di elaborare un nuovo modello educativo, consapevole, esplicito, intenzionale, globale, integrale. Questo è fatto da una idea di educazione viva, che si mette in ascolto, che sa interpretare Il progetto di Dio scritto nel cuore delle persone, che ha una grande stima e capacità non solo di leggere, ma di sostenere e rinforzare una autentica libertà. E’ un progetto esplicito che è insieme pensiero e decisione, capace di costruire alleanze educative, comunità educanti, perché va risvegliata una corresponsabilità nell’educare, fatta di pazienti legami senza deleghe. Alla base ci sta una grande passione educativa. Educare non è una penitenza, un supplizio, come lo fanno capire tanti educatori, insegnanti, genitori stessi, ma una bellezza e una passione. Educare fa crescere anche te, ti restituisce il centuplo, ti pone sempre nella prospettiva di un cambiamento e di una novità. Non si deve chiudere la schiera di santi educatori che hanno popolato la comunità cristiana e civile nei secoli passati.
Università popolare dell’educazione.
Possiamo forse dare corpo a un sogno: quello di una università popolare dell’educazione, che non ci incasella nei gradi accademici, ma che da tale mondo prende la passione della ricerca, e opera secondo logiche di coinvolgimento, di confronto tra cultura e esperienza quotidiana, si immerge nei problemi reali, sa far vibrare e dare dignità culturale a tutto quell’associazionismo popolare che spende nell’educazione di generazioni di ragazzi e giovani tutte le sue creatività ed energie e non è nemmeno riconosciuto se non da qualche elemosina. Un esempio di tale tendenza a dare voce alla cultura di popolare è la bella esperienza dell’educazione del turista o del pellegrino alla bellezza della vita di fede tramite l’arte, dentro un progetto di messaggi competenti, affascinanti, proposti con intelligenza e passione, come l’eco di una vita credente convinta e testimonial, che convince per la passione della comunicazione e per la libertà lasciata alla intelligenza delle decisioni di ciascuno (Verdon).
Formazione degli adulti.
Restituire alla comunità cristiana la possibilità di vedere protagonisti i laici passa attraverso quella particolare produzione di cultura che è costituita dalla formazione degli adulti. Formazione, per gli adulti significa possibilità di interpretare la propria esistenza quotidiana e le esperienze che la scandiscono, potendo fare di essa una rivisitazione critica, libera e credente. Questo non avviene con proposte modellate sulla esperienza scolastica e con la raccomandazione agli adulti di interessarsi dei piccoli. La formazione degli adulti è una vera e propria forma di elaborazione culturale, di ricerca condivisa che sa indugiare su tutti gli spazi della vita per raggiungere gli spazi della fede e non sentirsi sempre solo. La cultura non segue le vie dell’omologazione o dell’organizzazione, ma della libertà e della creatività (Bignardi). Qui la corresponsabilità la si impara provandola, sperimentando se stessi nel proprio rapporto con gli altri e con gli ideali alti, rischiando anche di sbagliare, dando fiducia sempre.
Corresponsabilità per lavoro, nella pastorale, con la famiglia.
Un modo intelligente di vivere la corresponsabilità è stata ed è tuttora l’esperienza chiamata progetto Policoro, dove si sono alleati uffici pastorali (giovani, caritas e pastorale sociale), associazioni ecclesiali, istituti di ricerca, associazioni professionali e enti statali, nel tentativo di rompere quella assuefazione del mondo del Sud alla mancanza di lavoro e difficoltà nella imprenditorialità. Si sono verificati miracoli di collaborazione, filiere (così le chiamava don Operti) impensabili, risorse sepolte e portate alla luce e alla operatività. Vengono preparati giovani capaci di fare gli imprenditori, non più passivi nella ricerca del lavoro, orientati a dare alla fede lo spazio di una formazione integrale a partire dalla vita. Questo ha fatto capire che non ci può essere vera corresponsabilità laicale se questa non viene vissuta anche all’interno della curie, o meglio, della settorializzazione delle pastorali. Corresponsabilità allora non è solo compito o dovere del laico, ma è stile nuovo di tutta la chiesa. La fatica a far collaborare uffici pastorali è più grande spesso che quella del far lavorare assieme realtà pubbliche. Coprogettazione e comunicazione interna alla chiesa è oggi un obbligo dovuto (Livia). Siamo tutti convinti che le parrocchie oggi non sono autosufficienti, ma non lo sono nemmeno le diocesi e le stesse conferenze episcopali nazionali. Essere cattolici è ancora una visione di là da venire nelle nostre ristrette visioni territoriali. Non si può stare alla finestra pensando che sono solo i laici che devono fare comunione e vivere da corresponsabili. Un altro versante decisivo e un campo assolutamente determinante è la corresponsabilità della famiglia e per la famiglia, sia come esperienza che deve arricchire della sua esemplarità tutta la organizzazione della chiesa, sia per la necessità di renderla protagonista di se stessa e corresponsabile in tutti i campi della vita umana e dell’educazione alla fede. Una comunità cristiana che si modella sulla famiglia ha tutto da guadagnare e soprattutto ha da imparare. Perché la comunità cristiana è costruita da due sacramenti, quello dell’ordine e del matrimonio. Non basta l’ordine e nemmeno il matrimonio da solo (Bellomaria). Corresposnabilità della famiglia significa un nuovo modo di fare iniziazione cristiana, di accogliere e dare senso alle relazioni quotidiane, naturalezza di un rapporto preti famiglie, mutua comprensione degli errori e condivisione dei percorsi di rinascita
Il quadro della corresponsabilità è più ricco di una rivendicazione, è più vivo di un dovere, è più aperto di un impegno, è più concreto di un sogno, è più vero di una illusione, è una vocazione esigente cui Dio chiama tutti i battezzati, nessuno escluso.
Lettera al laico
Come nella tradizione delle Settimane Nazionali di Aggiornamento Pastorale organizzate dal COP, le prospettive pastorali trovano una traduzione originale in una lettera che può essere ripresa anche nei cammini pastorali delle comunità concrete perché la semina di questi giorni sia portata in profondità e produca abbondanti frutti.
Caro laico,
mentre ti scrivo davanti a me ho il volto e la storia di uomini e donne, giovani, sposi, sacerdoti, vescovi, persone in carne ed ossa che sono e siamo il popolo di Dio. Nel corso della storia della Chiesa, si è sempre cercato di ridefinire spazi, identità, ruoli reciproci. Se volessimo paragonare la Chiesa ad una casa potremmo dire così: preti e laici vivono tutti all'interno, non in piani diversi e tanto meno preoccupati nell'apporre la targhetta di rivendicazione all'esterno delle nostre camere. La vita vera e genuina la sperimentiamo quando ci incontriamo in cucina, in sala da pranzo, ovvero, nelle relazioni senza filtri, immediate, quando siamo capaci gli uni e gli altri di riconoscerci e testimoniarci di essere popolo amato e convocato da Dio, umili e onesti nell'uscire al di fuori di noi stessi per servire gli uomini in modo vero.
Ti si chiede di fare, di esserci, di dare una mano, di garantire servizi ecclesiali, di irrobustire la catechesi, animare la liturgia, servire nella carità. Servizi quasi tutti rivolti all'interno della parrocchia, della diocesi, ma tu ci fai presente quale laico, che devi pensarti e vederti come chiesa in mezzo agli uomini e alle donne che sono tentati di sostituire Dio con altro, come se fosse lo sfondo di un desktop dell'Ipad di fine tecnologia digitale. Vuoi essere attivo nelle scienze, negli studi di ricerca medica, nelle istituzioni amministrative di paesi e città, in delicati ambiti della vita, nella quotidianità della tua stessa famiglia. Ti vedo vivere in questi luoghi che, come la famiglia, costituiscono la nostra stessa unica casa che è la Chiesa; devo credere che la corresponsabilità si fa strada per vie e sentieri che non necessariamente partono e nascono dalla comunità cristiana e che in nome di essa ti senti responsabile, perdendoci spesso anche la faccia.
Preti e laici, tutti siamo chiamati alla santità e ad annunciarla con la vita, con scelte concrete nel fare il prete, nel matrimonio, nella vita consacrata. Abbiamo una missione comune: annunciare il Vangelo. Le relazioni che sono il perno della vita di una comunità cristiana, le dobbiamo sviluppare nella direzione di una matura corresponsabilità. Una Chiesa tutta ministeriale non è una Chiesa clericalizzata ma popolata anche di laici autentici ed evangelizzatori. E anche per lo stesso sacerdote non si tratta di togliergli la responsabilità di governo, ma di favorire il lavoro comune ciascuno con il suo livello di responsabilità.
La sfida della corresponsabilità la affrontiamo anche nel campo dell’educazione per dare vita a progetti, esperienze, iniziative in grado di raccogliere le sfide del tempo, con esperienze popolari disseminate sul territorio, capaci di fare opinione e di generare un tessuto ecclesiale e culturale vivo.
La corresponsabilità che viviamo è più ricca di una rivendicazione, è più viva di un dovere, è più aperta di un impegno, è più concreta di un sogno, è più vera di una illusione, è una vocazione esigente cui Dio chiama tutti i battezzati, preti e laici, nessuno escluso.
I “sognatori” di Firenze 2011