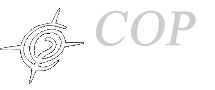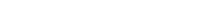Campanini: più fiducia in un laicato che abbia maggiore consapevolezza delle sue potenzialità
“Un laicato incapace di uscire dalle sagrestie non potrà mai dar luogo a quella presenza nel mondo che pure la gerarchia invoca. Il rischio: che l'insistente ricorso al termine di corresponsabilità determini nel laicato cattolico un senso di frustrazione per la distanza che ricorre tra i principi e la realtà delle cose”. È il richiamo che il sociologo Giorgio Campanini ha rivolto alla Settimana di aggiornamento pastorale, parlando di corresponsabilità “nella missione evangelizzatrice della Chiesa”. Campanini ha osservato che tra il laicato prevale “un’interpretazione del proprio ruolo storico sul versante laico-Chiesa piuttosto che su quello Chiesa-mondo”, ossia “si avverte l’impulso a operare per l’evangelizzazione all’interno della comunità cristiana, lasciando tuttavia in ombra il rapporto tra il laico cristiano e il mondo”; al contempo “l’istituzione ecclesiastica sembra in taluni momenti avvertire assai più l’esigenza di contrastare, del resto doverosamente, alcune derive presenti nei delicati ambiti della vita, della famiglia, dell’educazione, che non quella di valorizzare l’impegno dei laici nella storia, avendo presente il vasto ventaglio delle problematiche legate al rapporto Chieda-mondo”. “S’impone, su questo sfondo, da parte dei laici una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella storia; da parte delle gerarchie ecclesiastiche una più convinta fiducia nel laicato e il rifiuto della tentazione del protagonismo, con l’inevitabile tendenza all’invasione di spazi che dovrebbero essere riservati l responsabile esercizio della laicità”. Ma “per i laici essere corresponsabili della missione della Chiesa – ha aggiunto Campanini – significa innanzitutto evangelizzare nel mondo” e “il luogo primario in cui la fedeltà al mondo assume piena concretezza – quella stessa concretezza che fa della Chiesa, sempre, una Chiesa locale – è il territorio”. “Il paradosso delle società industriali – ha osservato – è quello di avere un popolo composto di ‘residenti’ e insieme d’itineranti”, con “una forte mobilità insieme interna ed esterna, fisica e mentale”: da una parte c’è la spinta alla mobilità e dall’altra la resistenza a questa mobilità, da cui “l’abbandono alle origini” e “la ricerca, talora esasperata, di vere o presunte ‘origini’”. Di fronte a questo scenario occorre “imparare a vivere nel territorio, conoscendolo nella sua realtà e attraverso la sua storia senza, nello stesso tempo, fare di esso un feticcio”. “Per i laici presenti nel mondo – ha precisato il sociologo – evangelizzare significa ‘sposare’ i propri ambienti di vita, assumendo i problemi e le sofferenza del mondo, facendosi carico dei problemi di compagni di strada: in una parola, superare la tentazione dell’estraneità e abbandonare il tranquillo recinto di una comunità cristiana chiusa e autoreferenziale”. “Il concetto di corresponsabilità – ha concluso – si esprime in una duplice dimensione: da una parte vi è chi assume una responsabilità e dall’altra che la riconosce, l’accoglie, la valorizza. La corresponsabilità implica dunque un incontro e un dialogo, non la separatezza o la contrapposizione, e in questo senso è, o dovrebbe essere, lo stile tipico della Chiesa”.
De Palo: superare i particolarismi per costruire percorsi di fraternità vera.
“Il cristiano, soprattutto in questo tempo di fragilità e di complessità, è chiamato a sfidare il futuro con i piedi per terra affermando la sua speranza in Dio, nonostante tutto”. Così ha esordito Gianluigi De Palo, assessore alla famiglia, all’educazione e ai giovani del Comune di Roma Capitale, parlando alla Settimana Cop. “Corresponsabilità è uscire dalla logica della delega, agire in virtù del proprio battesimo. È prendersi le proprie responsabilità e, quindi, vivere da adulto ogni scelta con la consapevolezza che abbia a che fare con il Vangelo. Credo – ha aggiunto – che una vera corresponsabilità significhi per i laici una missione profetica nella Chiesa, in due direzioni: nella presenza all’interno delle strutture sociali, politiche e amministrative, essendo chiamati a essere protagonisti di un profondo rinnovamento degli stili di vita, e attraverso una nutrita e seria formazione, chiamati ad aprire nuove strade per l’evangelizzazione. Oltre il linguaggio della contestazione, con modalità nuove affinché il laicato non sia più una componente di collaboratori disponibili, ma una vocazione a cui è stato affidato un pezzo di responsabilità nella Chiesa”. “Per fare tutto questo, però, è necessaria – ha rimarcato l’assessore – una formazione più attenta e puntuale a questa visione di Chiesa sia per quanto riguarda i sacerdoti, sia per i religiosi e i laici. È necessario migliorare l’impostazione pastorale, cosicché, nel rispetto delle vocazioni e dei ruoli dei consacrati e dei laici, si promuova gradualmente la corresponsabilità dell’insieme di tutti i membri del popolo di Dio”. A questo proposito, De Palo ha portato l’esempio del suo impegno in politica lamentando che “la libertà e l’autonomia presuppongono una maturità che non sempre è presente nelle nostre comunità”, con “divisioni all’interno del mondo cattolico tra movimenti, associazioni e realtà ecclesiali”. “Per il solo fatto di aver accettato di mettermi al servizio della mia città e di entrare in una giunta di un certo schieramento politico – ha raccontato – sono diventato un ‘nemico’ per quelli che hanno votato per l’altro schieramento. Una situazione paradossale, dove amici di lunga data con cui condividevamo giornate passate sui tavoli dei vari assessorati a lavorare per il bene comune improvvisamente mi percepiscono come un appestato. Credo che oggi essere corresponsabili sia rompere lo schema bipolare o tripolare che abbiamo nelle nostre teste e che c’impedisce di accettare che qualcosa di buono possa arrivare anche da chi non la pensa come noi. Guelfi e ghibellini, rossi, neri e bianchi… Coppi e Bartali. Questo è l’Italia. Ma forse un tempo ce lo potevamo permettere, oggi non più. È questo il tempo di superare i particolarismi, le chiusure, i piccoli recinti, per costruire percorsi d fraternità vera e di comunione”.

Blasetti: Comunità Emmanuel, esempio di corresponsabilità nella vita affettiva e nella fragilità
“La corresponsabilità nella vita affettiva e nella fragilità ha bisogno di essere pensata ma anche fatta”. Don Paolo Blasetti, fondatore della Comunità Emmanuel, ha declinato quest’assunto presentando un’esperienza concreta, ovvero la Comunità Emmanuel, nata a Lecce e poi diffusa in tutt’Italia, dedicata all’accoglienza di persone che vivono in condizione di marginalità (extracomunitari, tossicodipendenti, senza dimora ecc.).
La comunità, ha raccontato, “nasce da un gruppo di preghiera di laici che nel loro itinerario si sono domandati come potessero incarnare nella storia e nella quotidianità la loro fede, come cioè la loro esperienza di Dio li aprisse all’incontro con gli uomini nell’area affettiva e della fragilità”. “Non un individuo che pensa un progetto, ma un gruppo di persone”, ha precisato Blasetti, e “questo ha innescato un movimento profondo di discernimento comune” che ha portato, all’inizio degli anni Ottanta, alla nascita della Comunità. “L’accoglienza – ha aggiunto – prima ancora che un luogo fisico logistico è un luogo umano e come Dio ha condiviso la nostra condizione umana accogliendola, così si è chiamati ad accogliere non offrendo una struttura, ma il ‘mettere vita con vita’, il farsi compagni di cammino a chiunque bussi alla porta”.

Bignardi: un nuovo modello educativo consapevole, esplicito, intenzionale, globale, integrale
“Non saranno né la rivendicazione, né la lamentazione a cambiare la situazione ecclesiale e l’impostazione delle comunità cristiane. Saranno piuttosto presenze laicali che, senza perdere i contatti con la comunità cristiana, sapranno dare vita a esperienze, progetti, iniziative in grado di raccogliere le sfide di questo tempo. E questo a livello di base, con esperienze disseminate sul territorio: sono fin troppe le iniziative realizzate a livello di piccole elite, incapaci di fare opinione e di generare un tessuto ecclesiale e culturale vivo”. Così Paola Bignardi, già presidente dell’Azione cattolica italiana e ora membro del Comitato per il progetto culturale della Cei, ha parlato alla Settimana di aggiornamento pastorale, riconoscendo la presenza di una “crisi dei laici” che “si esprime nel privilegiare in maniera quasi esclusiva l’impegno intraecclesiale, nel quale spesso si scontrano con una mentalità clericale che ritiene che quello intraecclesiale sia ambito proprio, quando non esclusivo, del prete”; si esprime poi con “una regressione ad atteggiamenti tipici delle età più immature”, che hanno “un bisogno esagerato di approvazione e di benedizioni ecclesiastiche alle loro iniziative di laici”; nonché “è crisi di iniziative, di progettualità, di cultura, di proposte, di responsabilità”. L’ex presidente dell’Azione cattolica si è quindi concentrata sulla corresponsabilità in materia educativa, rispetto alla quale, ha detto, “la crisi dei processi educativi tradizionali richiede l’elaborazione di un nuovo modello educativo consapevole, esplicito, intenzionale, globale, integrale”. “Questo – ha precisato – ha bisogno almeno di un’idea di educazione viva, un impegno a costruire alleanze educative, un progetto educativo attuale, la passione educativa”. All’interno di un’educazione viva, “l’educatore non conduce i più giovani dove vuole, secondo la sua sensibilità e le sue preferenze, ma li conduce a trarre da sé il tesoro nascosto nella loro vita”. “Per questo – ha aggiunto – l’educatore vero è prima di tutto una persona in ascolto” e “il suo condurre nasce da qui: dalla sensibilità con cui sa interpretare il progetto di Dio scritto nel cuore delle persone che gli sono affidate”. “L’educatore – ha evidenziato – accoglie, propone, accompagna, sostiene, ma nel rispetto della libertà della persona chiamata a diventare se stessa”, essendo “disposto persino ad accettare che alla fin fine sia diversa da come la vorrebbe”. In secondo luogo l’impegno a “costruire alleanze educative” attraverso una “comunità educante” non significa “demandare alla comunità la responsabilità di educare” o “delegare l’educazione alle istituzioni”, quanto piuttosto “riconoscere che vi è una responsabilità diffusa verso le giovani generazioni e che tale responsabilità viene assunta dalla forza e dalla qualità dei legami che tengono insieme una comunità”. Ancora, “occorre tornare a riferirsi a un progetto educativo” che sia “attuale”, “dando all’educazione prospettive di vasto orizzonte”; un progetto che “si qualifica per il suo orientamento ai valori, per i principi fondamentali che assume a fondamento e, in ultima istanza, per l’idea di persona che assume”. Infine, “occorre oggi riscoprire la bellezza e la passione di educare”: “l’educazione, assunta con responsabilità e con impegno, può costituire una straordinaria avventura umana, avventura che segna la maturità di un adulto, qualunque sia la sua condizione e le sue scelte esistenziali”.